Le ceneri di Pasolini. Il romanesco ovvero l’anti-dialetto, la lingua franca dei popoli migranti.
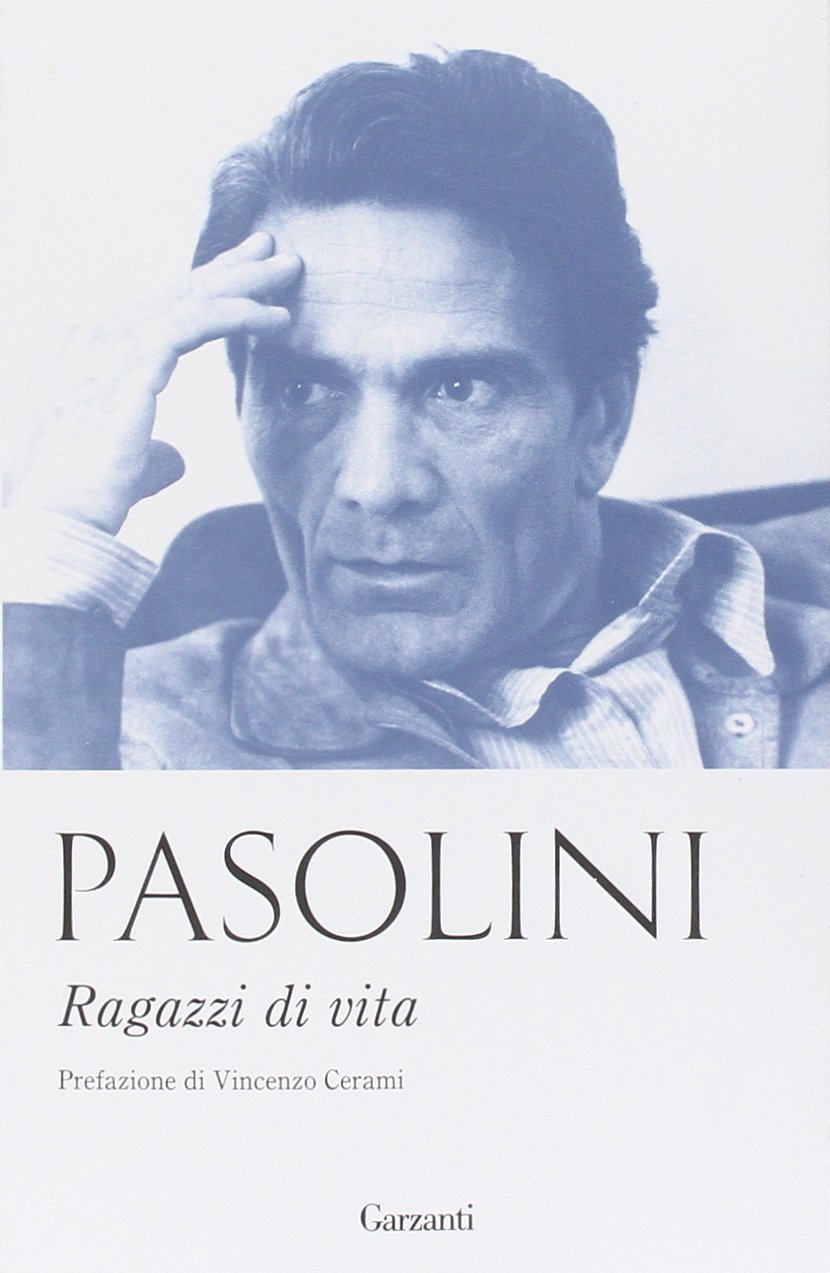
Le ceneri
di Pasolini
Il romanesco ovvero
la lingua franca
dei migranti
Tratto da F. Berti,
Trilussa contro Maciste,
Seconda edizione, 2020
I poveri creano le lingue e poi seguitano a rinnovarle all’infinito, mentre i ricchi le cristallizzano per poter sfottere chi non parla come loro. Così scrive don Lorenzo Milani nella sua Lettera a una professoressa. Provocazione in cui si richiama all’idea che le lingue nazionali vengano a svilupparsi dai dialetti formalizzati per convenienza politica e successivamente imposti agli stessi poveri che li avevano elaborati, con le nuove regole dettate dai ricchi. Ogni lingua passa da una koiné dialettale prima d’imporsi, Riccardo Regis parla a questo proposito di un dialetto ‘epurato’ che risolve nei suoni e nelle forme dei grandi centri regionali, descrivendo così di fatto quella che si può considerare l’essenza stessa del romanesco da sempre nella città del mondo, la nuova Babilonia, luogo d’incontro per definizione dove tutte le strade conducono, da cui tutte le strade partono. Dante Alighieri volutamente sorvola sul romanesco del Trecento, considerandolo a malapena un osceno turpiloquio.
“Poiché i Romani ritengono di dover essere posti davanti a tutti gli altri, sarà giusto che li mettiamo davanti agli altri in quest’opera di bonifica e di estirpazione, dichiarando che essi non sono da prendere in considerazione in nessun trattato dell’eloquenza volgare. Diciamo infatti che quello dei Romani, non volgare, ma piuttosto tristiloquio, è il più turpe di tutti i volgari italiani.“
Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, I-9.
Alla morte di Dante Roma si trova in uno stato di profonda decadenza, dopo la cattività avignonese del papato la popolazione è diminuita a 25.000 unità che parlano una variante dei dialetti meridionali arricchiti dalle espressioni colorite d’un gergo non ancora assurto a dignità letteraria. Il romanesco del Trecento non è dunque lo stesso del Cinquecento, il ritorno della sede papale in Vaticano ha prodotto una spinta immigratoria da ogni parte del territorio italiano verso Roma, con significativa presenza di toscani sia per quanto riguarda l’ambiente finanziario e mercantile, sia quello delle maestranze artistiche. Fiorentini in prima linea, forse per via di quel partito guelfo che aveva preso il sopravvento. Con la crescita demografica, la città attira in particolar modo banchieri, mercanti, pittori, scultori e architetti dalla Toscana, Riccardo Regis afferma che in quegli anni la tensione linguistica tra romani e non romani si risolve per l’appunto nella creazione di un romanesco medio, nel quale si azzerano gli elementi più marcatamente locali, non assimilabile né al toscano, né al romanesco popolare. Il dialettologo Orlandino Zuccagni non trova nel 1560 nessuno che gli traduca nel volgare del posto un testo evangelico: se in quasi tutte le città italiane si parla il dialetto, a Roma si parla di fatto una koiné dialettale del toscano.
La storia però non si ferma e nella prima metà del XVI secolo l’Urbe viene ulteriormente sconvolta da una serie di devastazioni passate alla cronaca del tempo come il sacco dei lanzichenecchi, al seguito della cui calata il popolo romano si ridurrà nuovamente a 20.000 unità. Una tragedia umana, oltre che politica e culturale, nei tre secoli successivi sarà di nuovo l’immigrazione a ripopolare la città portando l’incremento demografico a quelle 170.000 unità di romani censiti nel 1861, quando la città entra a far parte del regno d’Italia. La quasi totalità del popolo romano parla allora un dialetto che non corrisponde a quello del Trecento, né a quello del Cinquecento, ma a una nuova koiné cristallizzatasi intorno alle opere in volgare degli intellettuali al servizio dei signori locali. E’ il romanesco del Verucci, del Bernini, del Pianelli , del Berneri, nobilitato dalla poesia vernacolare di un neoclassicismo aristocratico e borghese. Una letteratura destinata in parte a coloro che finanziavano gli scrittori per magnificare l’autorità e il potere, in parte a quel popolo romano sempre più arricchito dai flussi migratori. Tutta la storia di Roma ‘caput mundi’ è segnata da questo movimento incessante, spezzato solo dalle tragedie demografiche di tanto in tanto, per cui si può affermare senza ombra di dubbio che il popolo di Roma è per eccellenza un popolo di clientes immigrati da ogni parte della penisola, dell’Europa e del mondo. Il romanesco è per eccellenza l’anti-dialetto, la lingua franca dei popoli migranti.
A questo proposito viene citato da Sergio Frasca il caso praticamente unico sul territorio italiano, di un romanesco da secoli confinato entro le mura cittadine che scompare nelle immediate vicinanze, fenomeno assente negli altri dialetti i quali invece si estendono, pur con le inevitabili varianti, ben oltre l’orizzonte della città. Fino a pochi anni fa a Frascati o ad Albano la parlata era completamente diversa nonostante i contatti tra la capitale e i vicini dintorni fossero molto stretti. Paradosso che si può spiegare con il melting pot culturale venutosi a creare nell’Urbe a partire dal XVI secolo dando luogo a una lingua ‘franca’, nata per facilitare i commerci con i pellegrini. A partire dal secolo romantico, quella lingua franca verrà istituzionalizzata proprio da Gioachino Belli, che finirà per imbrigliarla in un preteso volgare ‘romanzo’ creando così una frattura tra il romanesco letterario e quello parlato realmente dal popolo di Roma. Da quel momento in poi, la spinta nazionalistica porterà quella forma dialettale a imborghesirsi e ingentilirsi, fino al paradosso fascista del vernacolo nazional popolare che trova in Trilussa e Pascarella i suoi epigoni. Non è il dialetto parlato dal popolo delle borgate romane, in continua espansione, ma quello della borghesia intellettuale che reinventa la lingua del ‘buon selvaggio’, la quale per l’appunto prende il nome di romanesco, non di romano. Un’invenzione o per dirla in un senso strettamente linguistico, una koiné letteraria.
Nel frattempo il mondo va avanti, l’espansione urbana e l’immigrazione porteranno in quegli stessi anni la popolazione a crescere fino a 3 milioni di abitanti negli anni ’60 del Novecento, venti volte di più rispetto all’epoca del Belli. L’incremento demografico nel resto della nazione non arriverà al raddoppio nello stesso lasso di tempo, confermando l’anomalia di quest’improvvisa espansione demografica. Come osserva ancora una volta Sergio Frasca a proposito dei romanzi di Pier Paolo Pasolini, nelle borgate suburbane come il Quadraro, Tor Pignattara, la Garbatella, si viene a creare una nuova lingua franca ‘adattiva’ che trova nel cinema e nella televisione, da quel momento sempre più condizionanti, un veicolo di diffusione. E’ il romanesco di Sordi, Manfredi e Gassman a imporsi nella seconda metà del secolo, di sicuro non l’osceno turpiloquio che Dante Alighieri nomina nel De vulgari. Il popolo inizia a parlare un linguaggio sempre più influenzato dall’immigrazione proveniente dal meridione. Per questo motivo Ragazzi di vita viene scritto da Pasolini affiancando all’italiano letterario del narratore, il gergo di quelle borgate sottoproletarie degli anni ’50 in cui lo scrittore si aggirava come osservatore distaccato, senza mai perdere quell’inflessione bolognese che lo caratterizzerà nelle interviste fino all’ultimo giorno.
Nell’ambito della polemica sociale, Pasolini non ricorre ad usare voci del dialetto del poeta Belli, poiché sono ormai famose e conosciute da tutti gli italiani. Dunque, lui fa uso del dialetto borgataro rifiutato dal ceto borghese. Quindi Pasolini si impegna a fare una ricostruzione filologica del modo in cui i giovani italiani si esprimono.
Ashraf Saied Mansour, Consistenza del gergo e del romanesco in “Ragazzi di vita” di Pier Paolo Pasolini – Un approccio morfo-sintattico e fonologico, in ‘Philology’ n.62 Giugno 2014
Nella seconda parte del secolo e in particolar modo sul finire del millennio il romanesco letterario è sempre più raro, ne rimane ancora qualche residuo lessicale nel cinema e nel teatro, in quegli attori che si ispirano per lo più al linguaggio scritto dal Belli, da Trilussa, quando non dal futurista Petrolini che tutto creò e tutto distrusse. Nelle borgate che hanno inghiottito Pasolini ormai è dilagante l’omologazione culturale e la parlata caratteristica del ‘coatto’ di periferia, che non ha più niente di letterario. La lingua inglese penetra nel frattempo talmente a fondo nel linguaggio tecnologico, scientifico, mediatico, la colonizzazione culturale dei paesi anglosassoni porta a un cambiamento al livello pre-linguistico, nel modo di pensare le frasi e di concepire il linguaggio stesso. Sarà sempre più frequente il ricorso al neologisma, alla storpiatura volontaria, all’uso delle parole composte, alla ricerca della rima interna, dell’allitterazione, alla musicalità del verso. Là dove si registra una generale crisi del dialetto e una sempre maggiore influenza delle accademie che, nel pur lodevole intento (solo apparente) di preservarlo, contribuiscono a irrigidirlo proprio trasformandolo in koiné pre-linguistica; il solo modo in cui un popolo ormai diffusamente scolarizzato, per quanto soggetto a un devastante analfabetismo funzionale, possa riappropriarsi della lingua che parla, è affiancare alla ricerca letteraria un’invenzione linguistica sempre più spinta a livelli surreali, rassegnandosi al sincretismo eretto a paradigma.
Ad aggravare questa già precaria situazione della poesia dialettale è la crisi della nozione di popolo seguita al crollo del muro di Berlino e al vuoto ideologico degli ultimi trent’anni, che hanno portato sempre più alla frammentazione dei gruppi sociali e all’implosione della coscienza di classe (tra i dominati, non tra i dominanti), fino al mostro distopico dei social networks. Il recupero di una forma dialettale si trova davanti a una scelta binaria obbligata: o perseguire la via del purismo letterario e del rigorismo accademico, contribuendo a quel processo d’imbalsamazione della lingua scritta propria delle accademie, o ripercorrere la strada che aveva indicato Pasolini ovvero riprendere il linguaggio parlato realmente nelle borgate e usarlo come strumento espressivo privilegiato. Il dialettale è in questo caso da intendersi nel senso proprio di alternativo alla lingua nazionale, quel giano bifronte della nuova koiné italo-anglofona della tecnocrazia liberista, assurta a strumento di oppressione e condizionamento del pensiero unico.
